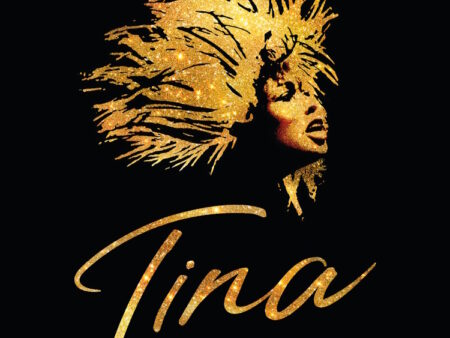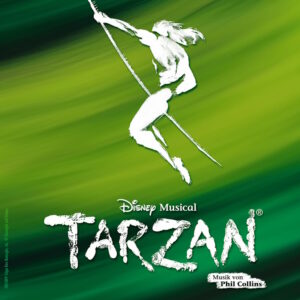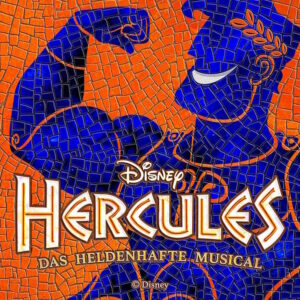Claudio Monteverdi
L’incoronazione di Poppea
Opera musicale
Libretto von Giovanni Francesco Busenello
Uraufführung: Herbst 1642, Teatro Santi Giovanni e Paolo, Venedig
Interlocutori
Fortuna,
Virtù,
Amore, Prologo
Poppea
Nerone
Ottavia
Ottone
Seneca
Drusilla
Nutrice
Arnalta
Lucano
Petronio
Tigellino
Famigliari di Seneca
Consoli
Tribuni
Littori
Liberto Capitano
Valletto
Due Soldati
Pallade
Venere
Choro d’Amori
Choro di virtù
Argomento
Nerone innamorato di Poppea, ch’era moglie di Ottone, lo mandò sotto pretesto d’Ambasciaria in Lusitania per godersi la cara diletta, così rappresenta Cornelio Tacito. Ma qui si rappresenta il fatto diverso. Ottone disperato nel vedersi privo di Poppea dà nei delirij, et nelle esclamationi. Ottavia moglie di Nerone ordina ad Ottone, che sveni Poppea. Ottone promette farlo; ma non bastandogli l’animo di levar la vita all’adorata Poppea, si traveste con l’habito di Drusilla, ch’era innamorata di lui. Così travestito entra nel giardino di Poppea. Amore disturba, et impedisce quella morte. Nerone ripudia Ottavia, non ostante i consigli di Seneca, prende per moglie Poppea. Seneca muore, e Ottavia vien discacciata da Roma.
Prologo
Fortuna, Virtù, Amore, Choro di Amori.
FORTUNA.
Deh, nasconditi, o virtù,
già caduta in povertà,
non creduta Deità;
nume, ch’è senza tempio,
Diva senza devoti, e senza altari,
dissipata,
disusata,
mal gradita,
et in mio paragon sempre avvilita.
Già regina, hor plebea, che per comprarti
gl’alimenti, e le vesti
i privileggi, e i titoli vendesti.
Ogni tuo professore,
se da me sta diviso
rimane un vacuo nullo
destituto da numeri, che mai
non rileva alcun conto,
sembra, un foco dipinto,
che né scalda, né splende;
resta un calor sepolto
in penuria di luce;
né alcun de tuoi seguaci speri mai
di conseguir ricchezze, o gloria alcuna,
se protetto non è dalla fortuna.
VIRTÙ.
Deh sommergiti, mal nata,
rea chimera delle genti,
fatta Dea degl’imprudenti.
Io son la vera scala,
per cui natura ascende al sommo bene.
Io son la tramontana,
che sola insegno agl’intelletti humani
l’arte del navigar verso l’Olimpo.
Può dirsi senza adulatione alcuna
il puro incorrotibile esser mio
termine convertibile con Dio,
che ciò non si può dir di te, Fortuna.
AMORE.
Che vi credete, o Dee,
divider fra di voi del mondo tutto
la signoria, e ‚l governo,
escludendone Amore,
Nume, ch’è d’ambi voi tanto maggiore?
Io le virtudi insegno,
io, le fortune domo;
questa bambina età
vince d’antichità
il tempo, e ogn’altro Dio,
gemelli siam l’eternitade, et io.
Riveritemi,
adoratemi,
e di vostro sovrano il nome datemi.
FORTUNA E VIRTÙ.
Human non è, non è Celeste core,
che contender ardisca con amore.
AMORE.
Hoggi in un sol certame
l’un, e l’altra di voi da me abbattuta
dirà, che il mondo a cenni miei si muta.
Fine del Prologo
Atto primo
Scena prima
Ottone, Due Soldati della Guardia di Nerone, che dormono.
OTTONE.
E pure io torno qui, qual linea a centro,
qual foco a sfera, e qual ruscello al mare,
e se ben luce alcuna non m’appare,
ahi, so ben io, che sta il mio Sol qui dentro.
Caro tetto amoroso,
albergo di mia vita, e del mio bene,
il passo, e ‚l core ad inchinarti viene.
Apri un balcon, Poppea,
col bel viso, in cui son le sorti mie,
previeni, anima mia, precorri il die.
Sorgi, e disgombra homai
da questo ciel caligini, e tenebre
con il beato aprir di tue palpebre.
Sogni, portate a volo,
fatte sentir in dolce fantasia
questi sospiri alla diletta mia.
Ma che veggio, infelice?
Non già fantasmi, o pur notturne larve,
son questi i servi di Nerone; ahi dunque
agl’insensati venti
io difondo i lamenti.
Necessito le pietre a deplorarmi.
Adoro questi marmi,
amoreggio con lagrime un balcone,
e in grembo di Poppea dorme Nerone.
Ha condotti costoro,
per custodir se stesso dalle frodi.
O salvezza de‘ Prencipi infelice,
dormon profondamente i suoi custodi.
Ahi perfida Poppea,
son queste le promesse, e i giuramenti,
ch’accesero il cor mio?
Questa è la fede, o Dio!
Io son quell’Ottone,
che ti seguì,
che ti bramò,
che ti servì,
che t’adorò,
che per piegarti e intenerirti il core
di lagrime imperlò preghi devoti,
gli spirti a te sacrificando i voti.
M’assicurasti al fine,
ch’abbracciate haverei nel tuo bel seno
le mie beatitudini amorose;
io di credula speme il seme sparsi,
ma l’aria, e ‚l Cielo a‘ danni miei rivolto
tempestò di ruine il mio raccolto.
Scena seconda
Due Soldati che si risvegliano.
PRIMO SOLDATO.
Chi parla, chi va lì?
Ohimè, ancor non è dì?
Sorgono pur dall’alba i primi rai
non ho dormito in tutta notte mai.
SECONDO SOLDATO.
Camerata, che fai?
Par che parli sognando.
Sù, risvegliati tosto,
guardiamo il nostro posto.
PRIMO SOLDATO.
Sia maledetto Amor, Poppea, Nerone,
e Roma, e la militia,
sodisfar io non posso alla pigritia
un’hora, un giorno solo.
SECONDO SOLDATO.
La nostra Imperatrice
stilla se stessa in pianti,
e Neron per Poppea la vilipende,
l’Armenia si ribella,
et egli non ci pensa,
la Pannonia dà all’armi, ei se ne ride,
così per quanto io veggio,
l’impero se ne va di male in peggio.
PRIMO SOLDATO.
Di‘ pur che il Prence nostro rubba a tutti,
per donar ad alcuni,
l’innocenza va afflitta,
e i scelerati stan sempre a man dritta.
SECONDO SOLDATO.
Sol del pedante Seneca si fida.
PRIMO SOLDATO.
Di quel vecchion rapace?
SECONDO SOLDATO.
Di quel volpon sagace.
PRIMO SOLDATO.
Di quel reo cortigiano,
che fonda il suo guadagno,
su’l tradire il compagno.
SECONDO SOLDATO.
Di quell’empio architetto,
che si fà casa sul sepolcro altrui.
PRIMO SOLDATO.
Non ridire ad alcun quel, che diciamo
nel fidarti va scaltro,
se gl’occhi non si fidan l’un dell’altro,
e però nel guardar van sempre insieme,
impariamo dagl’occhi,
a non trattar da sciocchi.
SECONDO SOLDATO.
Ma già s’imbianca l’alba e viene il dì;
taciam, Nerone è qui.
Scena terza
Poppea, Nerone.
POPPEA.
Signor, deh non partire,
sostien, che queste braccia
ti circondino il collo,
come le tue bellezze
circondano il cor mio;
a pena spunta l’alba, e tu che sei
l’incarnato mio Sole,
la mia palpabil luce,
e l’amoroso dì della mia vita,
vuoi sì repente far da me partita!
Deh non dir
di partir,
che di voce sì amara a un solo accento,
ahi, perir, ahi spirar quest’alma io sento.
NERONE.
Poppea, lascia, ch’io parta;
la nobiltà de‘ nascimenti tuoi
non permette, che Roma
sappia, che siamo uniti.
In fin che Ottavia non rimane esclusa
col repudio da me: Vanne, ben mio;
in un sospir, che vien
dal profondo del sen,
includo un bacio, o cara et un‘ a Dio,
ci rivedrem ben tosto, Idolo mio.
POPPEA.
Signor, sempre mi vedi,
anzi mai non mi vedi.
Perché s’è ver, che nel tuo core io sia
entro al tuo sen celata,
non posso da‘ tuoi lumi esser mirata.
Deh non dir
di partir,
che di voce sì amara a un solo accento,
ahi perir, ahi spirar quest’alma io sento.
NERONE.
Adorati miei rai,
deh restatevi homai.
Rimanti, o mia Poppea,
cor, vezzo, luce mia.
Non temer, tu stai meco a tutte l’hore,
splendor negl’occhi, e deità nel core.
Se ben io vò,
pur teco io stò,
il cor dalle tue stelle
mai mai non si divelle;
io non posso da te viver disgiunto
se non si smembra l’unità del punto.
POPPEA.
Tornerai?
NERONE.
Tornerò.
POPPEA.
Quando?
NERONE.
Ben tosto.
POPPEA.
Me’l prometti?
NERONE.
Te’l giuro.
POPPEA.
E me l’osservarai?
NERONE.
E s’a te non verrò, tu a me verrai.
POPPEA.
A Dio Nerone, a Dio.
NERONE.
A Dio, Poppea ben mio.
Scena quarta
Poppea, Arnalta.
POPPEA.
Speranza, tu mi vai
il Core accarezzando,
il genio lusingando,
e di agitarmi non desisti mai,
e mi circondi in tanto
di regio sì, ma imaginario manto,
no, no, non temo no di noia alcuna,
per me guerreggia Amore, e la Fortuna.
S’a tue promesse io credo,
già in capo ho le Corone,
e già ‚l divo Nerone
consorte bramatissimo possedo,
ma se ricerco il vero,
regina io son col semplice pensiero.
ARNALTA.
Ahi figlia, voglia il Cielo,
che questi abbracciamenti
non siano un giorno i precipitij tuoi.
L’imperatrice Ottavia ha penetrati
di Nerone gli amori,
ond’io pavento, e temo,
ch’ogni giorno, ogni punto
sia di tua vita il giorno, il punto estremo,
la prattica coi Regi è perigliosa,
l’amore, e l’odio non han forza in essi,
sono gli affetti lor puri interessi.
Se Neron t’ama, è mera cortesia,
s’ei t’abbandona non ten‘ puoi dolere.
Per minor mal ti converrà tacere.
Il Grande spira honor con la presenza,
lascia, mentre la casa empie di vento,
riputatione, e fumo in pagamento.
Perdi l’honor, con dir: Neron mi gode.
Sono inutili i vitij ambitiosi,
mi piaccion più i peccati fruttuosi.
Con lui tu non puoi mai trattar del pari,
e se le nozze hai per oggetto, e fine,
mendicando tu vai le tue ruine.
Mira, mira, Poppea,
dove il prato è più ameno, e dilettoso,
stassi il serpente ascoso,
dei casi le vicende son funeste.
La calma è profezia delle tempeste.
POPPEA.
Io mi fido d’amore, e di fortuna.
ARNALTA.
Ben sei pazza, se credi,
che ti possano far contenta, e salva
un garzon cieco, et una donna calva.
Scena quinta
Ottavia, Nutrice.
OTTAVIA.
Disprezzata Regina,
del Monarca romano afflitta moglie,
che fò, ove son, che penso?
O delle donne miserabil sesso:
se la natura e ‚l Cielo
libere ci produce,
il matrimonio c’incatena serve.
Se concepimo l’huomo
al nostro empio tiran formiam le membra,
allattiamo il carnefice crudele,
che ci scarna e ci svena,
e siam forzate per indegna sorte
a‘ noi medesme partorir la morte.
Nerone, empio Nerone,
marito, o Dio, marito
bestemmiato per sempre,
e maledetto dai cordogli miei,
dove ohimè, dove sei?
In braccio di Poppea,
tu dimori felice, e godi, e in tanto
il frequente cader de‘ pianti miei
pur va quasi formando
un diluvio di specchi, in cui tu miri
dentro alle tue dilitie i miei martiri.
Destin, se stai la sù,
Giove ascoltami tu,
se per punir Nerone
fulmini tu non hai,
d’impotenza t’accuso,
d’ingiustitia t’incolpo,
ahi, trapasso tropp’oltre, e me ne pento,
supprimo, e sepelisco
in taciturne angoscie il mio tormento.
O Ciel, o Ciel deh l’ira tua s’estingua,
non provi i tuoi rigori il fallo mio,
errò la superficie, il fondo è pio,
innocente fu il cor, peccò la lingua.
NUTRICE.
Ottavia, o tu dell’universe genti
unica Imperatrice,
di tua fida nutrice odi gl’accenti.
Se Neron perso ha l’ingegno
di Poppea ne‘ godimenti,
sciegli alcun, che di te degno
d’abbracciarti si contenti.
S’è l’ingiuria a Neron tanto diletta,
habbi piacer tu ancor nel far vendetta.
E se pur aspro rimorso
dell’honor t’arreca noia,
fa riflesso al mio discorso,
ch’ogni duol ti sarà gioia.
L’infamia sta gl’affronti in sopportarsi,
e consiste l’honor nel vendicarsi.
Han poi questo vantaggio
delle Regine gli amorosi errori,
se li sà l’idiota non li crede,
se l’astuto li penetra, li tace,
e ‚l peccato tacciuto e non creduto
sta segreto, e sicuro in ogni parte,
com’un, che parli in mezzo un sordo e un muto.
OTTAVIA.
No, mia cara nutrice:
la donna appassionata, dal marito
per adultere brame
resta oltraggiata sì, ma non infame!
Per il contrario resta
lo sposo inhonorato,
se il letto marital li vien macchiato.
NUTRICE.
Figlia, e Signora mia, tu non intendi
della vendetta il principale arcano.
L’offesa sopra il volto
d’una sola guanciata
si vendica col ferro e con la morte.
Chi ti punge nel senso,
pungilo nell’onore,
se bene a dirti il vero,
né pur così sarai ben vendicata;
nel senso vivo te punge Nerone,
e in lui sol pungerai l’opinione.
OTTAVIA.
Così sozzi argomenti
non intesi più mai da te, nutrice.
Se non ci fosse né l’honor, né Dio,
sarei nume a me stessa, e i falli miei
con la mia stessa man castigherei,
e però lunge dagli errori in tanto
divido il cor tra l’innocenza, e’l pianto.
Scena sesta
Seneca, Ottavia, Valletto.
SENECA.
Ecco la sconsolata
donna, assunta all’impero,
per patir il servaggio: o Gloriosa
del mondo Imperatrice,
sovra i titoli eccelsi
degl’insigni Avi tuoi cospicua e grande,
la vanità del pianto
degl’occhi Imperiali è ufficio indegno.
Ringratia la fortuna,
che con i colpi suoi
ti cresce gl’ornamenti.
La cote non percossa
non può mandar faville;
tu dal destin colpita
produci a te medesma alti splendori
di vigor, di fortezza,
glorie maggiori assai, che la bellezza.
La vaghezza del volto, i lineamenti,
che in apparenza illustre
risplendon coloriti, e delicati,
da pochi ladri dì ci son rubbati.
Ma la virtù costante
usa a bravar le stelle, il fatto, e ‚l caso,
giammai non vede occaso.
VALLETTO.
Madama, con tua pace
io vo‘ sfogar la stizza, che mi move
il filosofo astuto, il gabba Giove.
M’accende pure a sdegno
questo miniator de‘ bei concetti.
Non posso stare al segno,
mentr’egli incanta altrui con aurei detti.
Queste del suo cervel mere inventioni
le vende per misteri, e son canzoni.
S’ei sternuta o sbadiglia,
presume d’insegnar cose morali,
e tanto l’assottiglia,
che moverebbe il riso a‘ miei stivali.
Scaltra filosofia dov’ella regna,
sempre al contrario fa di quel ch’insegna.
Fonda sempre il pedante
su l’ignoranza d’altri il suo guadagno,
e accorto argomentante
non ha Giove per Dio, ma per compagno,
e le regole sue di modo intrica,
ch’al fin né anch’egli sa ciò, ch’ei si dica.
OTTAVIA.
Tu mi vai promettendo
balsamo dal veneno,
e glorie da tormenti;
scusami; questi son, Seneca mio,
detti di prospettiva,
vanità speciose,
studiati artifici
inutili rimedi agl’infelici.
Neron tenta il ripudio
della persona mia
per isposar Poppea: si divertisca,
se divertir si può sì indegno esempio.
Tu per me prega il popolo, e’l Senato,
ch’io mi riduco, a porger voti al tempio.
VALLETTO.
Se non dài soccorso
alla nostra Regina in fede mia,
che vuo‘ accenderti il foco
e nella toga, e nella libreria.
Scena settima
SENECA.
Le porpore regali e Imperatrici,
d’acute spine, e triboli conteste
sotto forma di veste
sono il martirio a Prencipi infelici:
le Corone eminenti
servono solo a indiademar tormenti.
Delle Regie grandezze
si veggono le pompe, e gli splendori,
ma stan sempre invisibili i dolori.
Scena ottava
Pallade, Seneca.
PALLADE.
Seneca, io veggo in Ciel infausti rai,
che minacciano te d’alte ruine,
s’hoggi verrà della tua vita il fine,
pria da Mercurio avvisi certi havrai.
SENECA.
Venga la morte pur: costante e forte,
vincerò gli accidenti e le paure,
dopo il girar delle giornate oscure
è di giorno infinito alba la morte.
Scena nona
Nerone, Seneca.
NERONE.
Son risoluto in somma
o Seneca, o maestro,
di rimovere Ottavia
dal posto di consorte,
e di sposar Poppea.
SENECA.
Signor, nel fondo alla maggior dolcezza
spesso giace nascosto il pentimento.
Consiglier scelerato è il sentimento,
ch’odia le leggi, e la ragion disprezza.
NERONE.
La legge è, per chi serve, e se vogl’io,
posso abolir l’antica e indur le nove;
è partito l’Imperio, è il Ciel di Giove,
ma del mondo terren lo scettro è mio.
SENECA.
Sregolato voler non è volere,
ma (dirò con tua pace) egli è furore.
NERONE.
La ragione è misura rigorosa
per chi ubbidisce non per chi comanda.
SENECA.
Anzi l’irragionevole comando
distrugge l’ubbidienza.
NERONE.
Lascia i discorsi, io voglio a modo mio.
SENECA.
Non irritare il popolo e il Senato.
NERONE.
Del Senato e del popolo non curo.
SENECA.
Cura almeno te stesso, e la tua fama.
NERONE.
Trarrò la lingua a chi vorrà biasmarmi.
SENECA.
Più muti che farai, più parleranno.
NERONE.
Ottavia è infrigidita et infeconda.
SENECA.
Chi ragione non ha, cerca pretesti.
NERONE.
A chi può ciò, che vuol, ragion non manca.
SENECA.
Manca la sicurezza all’opre ingiuste.
NERONE.
Sarà sempre più giusto il più potente.
SENECA.
Ma chi non sa regnar, sempre può meno.
NERONE.
La forza è legge in pace, e spada in guerra,
e bisogno non ha della ragione.
SENECA.
La forza accende gli odi, e turba il sangue,
la ragion regge gl’huomini e gli Dei.
NERONE.
Tu mi sforzi allo sdegno; al tuo dispetto,
e del popolo in onta, e del Senato,
e d’Ottavia, e del Cielo, e dell’abisso,
siansi giuste od ingiuste le mie voglie,
hoggi, hoggi Poppea sarà mia moglie.
SENECA.
Siano innocenti i Regi,
o s’aggravino sol di colpe illustri;
s’innocenza si perde,
perdasi sol per guadagnare i Regni,
ché il peccato commesso
per aggrandir l’Impero
si assolve da se stesso;
ma che una femminella habbia possanza
di condurti agli errori,
non è colpa di Rege, e Semideo.
È un misfatto plebeo.
NERONE.
Levamiti dinanzi,
maestro impertinente,
filosofo insolente.
SENECA.
Il partito peggior sempre sovrasta,
quando la forza alla ragion contrasta.
Scena decima
Poppea, Nerone, Ottone in disparte.
POPPEA.
Come dolci, Signor, come soavi
riuscirono a te la notte andata
di questa bocca i baci?
NERONE.
Più cari e più mordaci.
POPPEA.
Di questo seno i pomi?
NERONE.
Mertan le mamme tue più dolci nomi.
POPPEA.
Di queste braccia mie gli stretti amplessi?
NERONE.
Idolo mio, deh in seno ancor t’havessi.
POPPEA.
Dimmi, Signor, e come
t’arrivarono al core
tante mie tenerezze innamorate?
NERONE.
O gioconde, o lascive, o delicate.
POPPEA.
Tanti sospiri miei?
NERONE.
Consolarli, o diletta, ogn’hor vorrei.
POPPEA.
I fervori dell’anima infiammata,
trashumanata in estasi amorosa?
NERONE.
O graditi, mia luce, o dilettosi.
POPPEA.
Languida ancora io sono,
e ‚l mio spirto morto
dentro alle tue dolcezze,
resuscitato per morire ancora
il mio caro Neron stringe, et adora.
NERONE.
Poppea, respiro appena;
miro le labbra tue,
e mirando ricupero con gl’occhi
quello spirto infiammato,
che nel baciarti, o cara, in te difusi.
Non è, non è più in Cielo il mio destino,
ma sta de‘ labbri tuoi nel bel rubino.
POPPEA.
Signor, le tue parole son sì dolci,
ch’io nell’anima mia
le ridico a me stessa,
e l’interno ridirle
necessita al deliquio il core amante.
Come parole l’odo,
come baci io le godo;
son de‘ tuoi cari detti
i sensi sì soavi, e sì vivaci,
che, non contenti di blandir l’udito,
mi passano a stampar su ‚l cor i baci.
NERONE.
Quell’eccelso Diadema ond’io sovrasto
degl’huomini, e de‘ Regni alle Fortune,
teco divider voglio,
e allhor sarò felice
quando il titolo havrai d’Imperatrice;
ma che dico, o Poppea!
Troppo piccola è Roma a‘ merti tuoi,
troppo angusta è l’Italia alle tue lodi,
e al tuo bel viso è basso paragone
l’esser detta consorte di Nerone;
et han questo svantaggio i tuoi begl’occhi,
che, trascendendo i naturali esempi,
e per modestia non toccando i Cieli,
non ricevon tributo d’altro honore,
che di solo silentio, e di stupore.
POPPEA.
A speranze sublimi il cor inalzo
perché tu lo comandi,
e la modestia mia riceve forza;
ma troppo s’attraversa, et impedisce
delle Regie promesse il fin sovrano,
Seneca il tuo Maestro,
quello stoico sagace,
quel Filosofo astuto,
che sempre tenta persuader altrui,
che il tuo scettro dipende sol da lui.
NERONE.
Quel decrepito pazzo ha tanto ardire.
Olà, vada un di voi
a Seneca volando, e imponga a lui,
che in questo giorno ei mora,
vuò che da me l’arbitrio mio dipenda,
non da concetti, e da sofismi altrui;
rinegherei per poco
le potenze dell’alma, s’io credessi,
che servilmente indegne
si movessero mai col moto d’altre.
Poppea sta di buon core,
hoggi vedrai ciò, che sa far, Amore.
POPPEA.
Se mi conduci, Amor,
a Regia Maestà,
al tuo tempio il mio cor
voto si appenderà,
spirami tutto in sen
fonte d’ogni mio ben,
al Trono innalza me,
Amor, ogni mia speme io pongo in te.
Le meraviglie, Amor,
son opre di tua man,
trascende gli stupor
il tuo poter sovran.
Consola i miei sospir,
adempi i miei desir,
al Trono etc.
Scena undicesima
Ottone, Poppea, Arnalta in disparte.
OTTONE.
Ad altri tocca in sorte
bere il licor, e a me guardar il vaso,
aperte stan le porte
a Neron, ed Otton fuori è rimaso,
siede egli a mensa a satollar sue brame,
in amaro digiun mor’io di fame.
Chi nasce sfortunato
di se stesso si dolga, e non d’altrui;
del tuo penoso stato.
POPPEA.
Aspra cagion, Otton, non son, né fui,
il destin getta i dadi, e i punti attende,
l’evento o buono, o reo da lui dipende.
OTTONE.
La messe sospirata
dalle speranze mie, da‘ miei desiri,
in altra mano è andata,
e non consente Amor, ch’io più v’aspiri,
Neron felice i dolci pomi tocca,
e solo il pianto, a me bagna la bocca.
POPPEA.
A te le calve tempie,
ad altri il crine la Fortuna diede,
s’altri i desiri adempie
hebbe di te più fortunato piede,
sì che te stesso, e tua Fortuna incolpa,
la disventura tua non è mia colpa.
OTTONE.
Sperai, che quel macigno,
bella Poppea, che ti circonda il core,
fosse d’Amor benigno
intenerito a prò del mio dolore,
hor del tuo bianco sen la selce dura
di mie morte speranze è sepoltura.
POPPEA.
Deh non più rinfacciarmi,
porta, deh porta il mantellino in pace,
cessa di più tentarmi,
al cenno Imperial Poppea soggiace;
ammorza il foco homai; tempra li sdegni
io lascio te per arrivare ai Regni.
OTTONE.
E così l’ambitione
sovra ogni vitio tien la Monarchia?
POPPEA.
Così la mia ragione
incolpa i tuoi capricci di pazzia.
OTTONE.
È questo del mio Amor il guiderdone?
POPPEA.
Modestia, olà, non più, son di Nerone.
OTTONE.
Ahi chi ripon sua fede in un bel volto,
predestina se stesso a reo tormento,
fabrica in aria, e sopra il vacuo fonda,
tenta palpare il vento,
ed immobili afferma il fumo, e l’onda.
ARNALTA.
Infelice ragazzo!
Mi move a compassione il miserello;
Poppea non ha cervello
a non gl’haver pietà;
quand’ero in altra età
non volevo gl’amanti
in lacrime distrutti,
per compassion gli contentavo tutti.
Scena dodicesima
OTTONE.
Otton torna in te stesso,
il più imperfetto sesso
non ha per sua natura
altro di humano in sé, che la figura.
Costei pensa al comando, e se ci arriva
la mia vita è perduta, ella temendo,
che risappia Nerone
i miei passati amori,
ordirà insidie all’innocenza mia,
indurrà con la forza, un, che m’accusi
di lesa maestà, di fellonia.
La calunnia da‘ grandi favorita
distrugge agl’innocenti honor, e vita.
Vo‘ prevenir costei
col ferro, o col veleno,
non mi vuo‘ più nutrire il serpe in seno.
A questo, a questo fine
dunque arrivar dovea
l’amor tuo, perfidissima Poppea!
Scena tredicesima
Drusilla, Ottone.
DRUSILLA.
Pur con sempre con Poppea,
o con la lingua, e col pensier discorri.
OTTONE.
Discacciato dal cor viene alla lingua,
e dalla lingua è consignato a venti
il nome di colei,
ch’infedele tradì gl’affetti miei.
DRUSILLA.
Il tribunal d’Amore
talhor giustitia fa:
di me non hai pietà,
altri si ride Otton del tuo dolore.
OTTONE.
A te di quanto son,
bellissima donzella
hor fo libero don;
ad altri mi ritolgo,
e tutto tuo sarò, Drusilla mia;
perdona, o Dio, perdona
il passato scortese mio costume.
Benché dell’error mio non mi riprenda,
confesso i falli andati,
eccoti l’alma mia pronta all’emenda.
Insin ch’io viverò,
t’amerà sempre, o bella,
quest’alma, che ti fu cruda, e rubella;
già, già pentita dell’error antico
mi ti consacra homai servo, et amico.
DRUSILLA.
Già l’oblio sepellì
gl’andati dispiacer,
è ver, Ottone, è ver,
che a questo fido cor il tuo s’unì?
OTTONE.
Drusilla, è ver sì, sì.
DRUSILLA.
Temo, che tu mi dica la bugia.
OTTONE.
Teco non può mentir la fede mia.
DRUSILLA.
M’ami dunque.
OTTONE.
Ti bramo.
DRUSILLA.
E come in un momento?
OTTONE.
Amor è foco, e subito s’accende.
DRUSILLA.
Sì, subite dolcezze
hora gode il mio cor, ma non le intende,
m’ami adunque.
OTTONE.
Ti bramo.
DRUSILLA.
Ti dican l’amor mio le tue bellezze.
Per te nel cor ho nova forma impressa,
i miracoli tuoi credi a te stessa.
Lieta men vado (Otton, resta felice)
hor hora a visitar l’Imperatrice.
OTTONE.
Le tempeste del cor tutte tranquilla:
d’altri Otton non sarà, che di Drusilla;
e pure al mio dispetto iniquo Amore,
Drusilla ho in bocca, et ho Poppea nel core.
Il fine del primo atto.
Atto secondo
Scena prima
Seneca, Mercurio dal Ciel in terra.
SENECA.
Solitudine amata,
eremo della mente,
romitaggio a‘ pensieri,
delitie all’intelletto,
che discorre e contempla
l’imagini celesti
sotto le forme ignobili, e terrene,
a te l’anima mia lieta sen viene,
e lunge dalla corte,
che insolente, e superba
fa della mia patientia anotomia:
qui tra le frondi, e l’herba
m’affidò in grembo della pace mia.
MERCURIO.
Vero amico del Cielo
apunto in questa solitaria chiostra
visitar ti volevo.
SENECA.
E quando, e quando mai
le visite divine io meritai?
MERCURIO.
La sovrana virtù, di cui sei pieno,
deifica i mortali,
e perciò son da te ben meritate
le celesti ambasciate.
Pallade a te mi manda,
e ti annuntia vicina l’ultim’hora
di questa frale vita,
e ‚l passaggio all’eterna, et infinita.
SENECA.
O me felice, dunque
ho vivuto sin’hora
degl’huomini la vita,
vivrò dopo la morte
la vita degli Dei,
Nume cortese, hoggi il morir m’accenni?
Hor confermo i miei scritti,
autentico i miei studi;
uscir di vita è una beata sorte,
se da bocca divina,
per rendermi immortal, esce la morte.
MERCURIO.
Lieto dunque t’accingi
al celeste viaggio,
al felice passaggio,
t’insegnerò la strada,
che ne conduce allo Stellato Polo,
Seneca, hor colà sù drizzo il mio volo.
Scena seconda
Liberto, Capitano della guardia de‘ Pretoriani, Seneca.
LIBERTO.
Il comando tiranno
esclude ogni ragione,
e tratta solo vïolenza, o morte.
Io devo riferirlo, e nondimeno
relatore innocente
mi par esser partecipe del male,
che a riferire io vado.
Seneca, assai m’incresce di trovarti,
mentre pur ti ricerco.
Deh, non mi riguardar con occhio torvo
se a te sarò d’infausto annuncio il corvo.
SENECA.
Amico, è già gran tempo,
ch’io porto il seno armato
contro i colpi del Fato.
La notitia del secolo, in cui vivo,
forastiera non giunge alla mia mente;
se mi arrechi la morte,
non mi chieder perdono:
rido, mentre mi porti un sì bel dono.
LIBERTO.
Nerone a me comanda.
SENECA.
Non più! T’ho inteso, et obedisco hor hora.
LIBERTO.
E come intendi prima, ch’io m’esprima?
SENECA.
La forma del tuo dire, e la persona,
che a me ti manda son due contrassegni
minacciosi e crudeli;
del mio fatal destino
già già son indovino;
Nerone a me t’invia
a imponermi la morte,
et io sol tanto tempo
frappongo ad ubidirlo,
quanto basti a formar ringraziamenti
alla sua cortesia, che mentre vede
dimenticato il ciel de‘ casi miei,
gli faccia sovvenir, ch’io vivo ancora
per liberare l’aria, e la Natura
dal pagar l’ingiustissima angaria
de‘ fiati, e i giorni alla vecchiaia mia.
Ma di mia vita il fine
non satierà Nerone;
l’alimento d’un vitio all’altro è fame;
il varco ad un eccesso a mille è strada;
ed è là sù prefisso,
che cento abissi chiami un sol abisso.
LIBERTO.
Signor, indovinasti;
mori, e mori felice,
che, come vanno i giorni
all’impronto del Sole
a marcarsi di luce,
così alle tue scritture
verran per prender luce i scritti altrui.
I nostri Imperatori
diventan dopo morte eterni numi,
e trionfante Roma,
quando un Prencipe perde, acquista un Dio.
Ma tu morendo, o Seneca felice,
havrai la Deitade.
Non l’havrà mai Nerone,
ché non s’ammette in Ciel Nume fellone.
SENECA.
Vanne, vattene, homai,
e se parli a Nerone avanti sera,
ch’io son morto, e sepolto gli dirai.
Scena terza
Seneca, e i suoi Famigliari.
SENECA.
Amici, è giunta l’hora
di pratticare in fatti
quella virtù, che tanto celebrai.
Breve angoscia è la morte;
un sospir peregrino esce dal core,
ov’è stato molt’anni,
quasi in hospitio, come forestiero,
e se ne vola all’Olimpo
della felicità soggiorno vero.
FAMIGLIARI.
Non morir Seneca, no.
UNO.
Questa vita è dolce troppo,
questo Ciel troppo sereno,
ogni amaro, ogni veneno
finalmente è lieve intoppo;
io per me morir non vuo‘.
UNO.
Se mi corco al sonno lieve
mi risveglio in sul mattino,
ma un avel di marmo fino
mai non dà quel che riceve.
Io per me morir non vuo‘.
FAMIGLIARI.
Non morir Seneca, no.
SENECA.
Sopprimete i singulti,
rimandate quei pianti
dai canali degl’occhi
alle fonti dell’anime, o miei cari.
Vada quell’acqua omai
a lavarvi dai cori
dell’incostanza vil le macchie indegne.
Altr’essequie ricerca,
che un gemito dolente
Seneca moriente.
Itene tutti a prepararmi il bagno,
che se la vita corre
come il rivo fluente,
in un tepido rivo
questo sangue innocente io vuo‘ che vada
a imporporarmi del morir la strada.
Scena quarta
La Virtù con un Choro di Virtù, Seneca.
CHORO di Virtù.
Lieto, e ridente
al Fin t’affretta,
ché il Ciel t’aspetta.
SENECA.
Breve coltello,
ferro minuto
sarà la chiave
che m’aprirà
le vene in terra,
e in Ciel le porte dell’eternità.
CHORO di Virtù.
Lieto, e ridente, etc.
SENECA.
A Dio grandezze,
pompe di vetro,
glorie di polve,
larve d’error,
che in un momento
affascinate, assassinate il cor.
CHORO di Virtù.
Lieto, e ridente, etc.
SENECA.
Già già dispiego il volo
da questa mia decrepità mortale,
e verso il choro vostro,
adorate virtudi, inalzo l’ale.
Scena quinta
Valletto, Damigella.
VALLETTO.
Sento un certo non so che,
che mi pizzica, e diletta;
dimmi tu, che cosa egli è,
damigella amorosetta.
Se sto teco, il cor mi batte,
se tu parti, io sto melenso,
al tuo sen divino latte,
sempre aspiro, e sempre penso.
Ti direi, ti farei,
ma non so quel che vorrei.
DAMIGELLA.
Astutello, garzoncello,
bamboleggia Amor in te,
se divieni amante, affé,
perderai tosto il cervello.
Tresca Amor per solazzo coi bambini,
ma siete Amor, e tu, due malandrini.
VALLETTO.
Dunque amor così comincia?
È una cosa molto dolce?
Io darei, per godere il tuo diletto,
i cireggi, le pera, et il confetto.
Ma se amaro divenisse
questo mel, che sì mi piace,
lo raddolciresti tu,
dimmelo, luce mia, dimmelo di‘?
DAMIGELLA.
L’addolcirei, sì, sì.
VALLETTO.
Ma come poi faresti?
DAMIGELLA.
Che dunque non lo sai?
VALLETTO.
Nol so, cara, nol so.
Dimmi come si fà.
Fa‘ ch’io lo sappia espresso,
perché se la superbia si ponesse
su ‚l grave del sussiego,
io sappia raddolcirmi da me stesso.
Mi par che per adesso,
se mi dirai, che m’ami,
io mi contenterò,
dimmelo dunque, o cara,
e se vivo mi vuoi, non dir di no.
DAMIGELLA.
T’amo, caro Valletto,
e nel mezzo del cor sempre t’havrò.
VALLETTO.
Non vorrei, speme mia, starti nel core,
vorrei starti più in sù.
Non so, se sia mia voglia o saggia, o sciocca
io vorrei, che ‚l mio cor facesse nido
nelle fossette belle, e delicate,
che stan poco discosto alla tua bocca.
DAMIGELLA.
Se ti mordessi poi?
Ti bagneresti in pianti tutto un dì.
VALLETTO.
Mordimi quanto sai,
mai non mi lagnerò,
morditure sì dolci
vorrei sempre goderle,
purché bacciato io sia da‘ tuoi rubini
mi mordan pur le perle.
Scena sesta
Nerone, Lucano, Petronio, Tigellino.
NERONE.
Hor che Seneca è morto,
cantiam, cantiam, Lucano,
amorose canzoni
in lode d’un bel viso,
che di sua mano Amor nel cor m’ha inciso.
LUCANO.
Cantiam, Signor, cantiamo
di quel viso ridente,
che spira glorie et influisce amori;
di quel viso beato
in cui l’Idea miglior se stessa pose,
e seppe su le nevi
con nova maraviglia
animar, incarnar la granatiglia.
NERONE.
Cantiam di quella bocca,
a cui l’India e l’Arabia
le perle consacrò, donò gli odori.
Bocca, ahi destin, che se ragiona, o ride,
con invisibil arma punge, e all’alma
dona felicità, mentre l’uccide.
Bocca che se mi porge
lasciveggiano il tenero rubino
m’inebria il cor di nettare Divino.
PETRONIO.
Tu vai, Signor, tu vai
nell’estasi d’amor deliciando,
e ti piovon dagl’occhi
stille di tenerezza,
lacrime di dolcezza.
NERONE.
Idolo mio, Poppea,
celebrarti io vorrei,
ma son minute fiaccole, e cadenti
dirimpetto al tuo Sole i detti miei.
TIGELLINO.
O Beata Poppea,
Signor, nelle tue lodi!
PETRONIO.
O beato Nerone
in grembo di Poppea!
TIGELLINO.
Di Neron.
PETRONIO.
Di Poppea cantiamo i vanti.
LUCANO.
Apra le cattaratte il Ciel d’Amore.
PETRONIO E TIGELLINO.
E diluvi, et inondi a tutte l’hore.
TUTTI.
Felicità sovra gl’amati amanti.
NERONE.
Son rubini amorosi,
tuoi labri pretiosi,
il mio core costante
è di saldo diamante,
così le tue bellezze, et il mio core
di care gemme ha fabbricato Amore,
son rose senza spine
le tue guancie divine,
gigli, e ligustri eccede
il candor di mia fede,
così tra il tuo bel viso, et il mio core
la primavera sua divide Amore.
Scena settima
Nerone, Poppea.
NERONE.
O come, o come a tempo,
bella adorata mia, mi sopragiungi!
Io stavo contemplando
col pensier il tuo volto,
hor con gli occhi idolatri io lo vagheggio;
occhi cari, occhi dolci,
al cui negro amoroso
cede la luce del più caro dì,
da voi lo strale uscì,
che mi piagò soavemente il core,
per voi vive Nerone, e per voi more.
POPPEA.
Et io non trovo giorno,
dove tu non risplendi,
e non vuole il cor mio,
ch’alcun’aria da me sia respirata,
se non è dal tuo viso illuminata.
Viso, che circondato
di maestà amorosa,
passando per quest’occhi al cor m’entrò,
ond’io per sempre havrò
del tuo divin sembiante, o mio Signore,
un ritratto negl’occhi, et un nel core.
NERONE.
Deh, perché non son io
sottile, e respirabile elemento,
per entrar, mia diletta,
in quella bocca amata,
che passerei per uscio di rubino
a baciar di nascosto un cor divino!
POPPEA.
Deh, perché non son io
l’ombra del tuo bel corpo, o mio Signore,
per assisterti sempre
in compagnia d’Amore!
Deh, faccia il Ciel, per consolar mio duolo,
di te, di me, Signor, un corpo solo.
NERONE E POPPEA.
Partiam, partiamo,
ben tosto si unirà.
Né più si scioglierà la destra, e ‚l core;
tu di là,
io di qua.
Ahi, che di pianto hormai le luci ho piene.
Ma ben presto verran l’hore serene.
Scena ottava
OTTONE solo.
I miei subiti sdegni
la politica mia già poco d’hora
m’indussero a pensare
d’uccidere Poppea?
o mente maledetta,
perché se‘ tu immortale, ond’io non posso
svenarti, e castigarti?
Pensai, parlai d’ucciderti, ben mio?
Il mio genio perverso,
rinegati gli affetti,
che un tempo mi donasti,
piegò, cadé, proruppe
in un pensier sì detestando, e reo?
cambiatemi quest’anima deforme,
datemi un altro spirto meno impuro
per pietà vostra, o Dei!
Rifiuto un intelletto,
che discorre impietadi,
che pensò sanguinario, et infernale
di offender il mio bene, e di svenarlo.
Isvieni, tramortisci,
scelerata memoria, in raccordarlo.
Sprezzami quanto sai,
odiami quanto vuoi,
voglio esser Clizia al Sol de‘ lumi tuoi.
Amerò senza speme
al dispetto del Fato,
fia mia delitia, amarti disperato.
Blandirò i miei tormenti,
nati dal tuo bel viso,
sarò dannato, sì, ma in Paradiso.
Scena nona
Ottavia, Ottone.
OTTAVIA.
Tu che dagli Avi miei
havesti le grandezze,
se memoria conservi
de‘ benefici havuti, hor dammi aita.
OTTONE.
Maestade, che prega
e destin, che necessita; son pronto
a servirti, o Regina,
quando anco bisognasse
sacrificare a te la mia ruina.
OTTAVIA.
Voglio che la tua spada
scriva gli oblighi miei
alla tua cortesia
col sangue di Poppea; vuo‘ che l’uccida.
OTTONE.
Che uccida chi?
OTTAVIA.
Poppea.
OTTONE.
Poppea?
OTTAVIA.
Poppea: perché dunque ricusi
quel che già promettesti!
OTTONE.
Io ciò promisi?
Urbanità di complimento humile,
modestia di parole costumate,
a che pena mortal mi condannate!
OTTAVIA.
Che discorri fra te?
OTTONE.
Discorro il modo
più cauto, e più sicuro
d’una impresa sì grande. O Cielo, o Dei,
in questo punto horrendo
ritoglietevi i giorni, e i spirti miei.
OTTAVIA.
Che mormori?
OTTONE.
Io voto alla Fortuna,
che mi doni attitudine a servirti.
OTTAVIA.
E, perché l’opra tua
quanto più presta sia, tanto più cara,
precipita gl’indugi.
OTTONE.
Sì tosto ho da morir?
OTTAVIA.
Ma che frequenti
soliloqui son questi? ti protesta
l’Imperial mio sdegno,
che se non vai veloce al maggior segno,
pagherai la pigritia con la testa.
OTTONE.
Se Neron lo saprà?
OTTAVIA.
Cangia vestiti.
Habito muliebre ti ricopra,
e con frode opportuna
sagace esecutor t’accingi all’opra.
OTTONE.
Dammi tempo, ond’io possa
inferocire i sentimenti miei,
dishumanar il core,
imbarbarir la mano,
assuefar non posso in un momento
il genio innamorato
nell’arti di carnefice spietato.
OTTAVIA.
Se tu non m’ubbidisci,
t’accuserò a Nerone,
ch’abbi voluto usarmi
violenze inhoneste,
e farò sì, che ti si stanchi intorno
il tormento, e la morte in questo giorno.
OTTONE.
Ad ubbidirti, Imperatrice, io vado.
OTTAVIA.
Vattene pure: la vendetta è un cibo,
che col sangue inimico si condisce.
Della spenta Poppea su ‚l monumento
quasi a felice mensa
prenderò così nobile alimento.
Scena decima
Drusilla, Valletto, Nutrice.
DRUSILLA.
Felice cor mio,
festeggiami in seno,
doppo i nembi, e gl’horror godrò il sereno.
Hoggi spero, che Ottone
mi riconfermi il suo promesso amore,
festeggiami nel sen, lieto mio core.
VALLETTO.
Nutrice, quanto pagaresti un giorno
d’allegra gioventù, com’ha Drusilla?
NUTRICE.
Tutto l’oro del mondo io pagarei.
L’invidia del ben d’altri,
l’odio di se medesma,
la fiacchezza dell’alma,
l’infirmità del senso
sono quattro ingredienti,
anzi i quattro elementi
di questa miserabile vecchiezza,
che canuta, e tremante
dell’ossa proprie è un cimiterio andante.
DRUSILLA.
Non ti lagnar così, sei fresca ancora;
non è il sol tramontato,
se ben passata è la vermiglia Aurora.
NUTRICE.
Il giorno femminil
trova la sera sua nel mezzo dì.
Dal mezzo giorno in là
sfiorisce la beltà;
col tempo si fa dolce
il frutto acerbo, e duro,
ma in hore guasto vien quel, ch’è maturo.
Credetel pure a me,
o giovinette fresche in su ‚l mattino;
bel sembiante gentil
passar non lasci April;
utile è Luglio, e Ottobre,
ma il frutto si raccoglie
tra secche paglie, e inaridite foglie.
VALLETTO.
Andiam a Ottavia homai
signora Nonna mia,
venerabile antica,
del buon Caronte idolatrata amica.
NUTRICE.
Ti darò una guanciata,
bugiardello insolente,
che sì, che sì.
VALLETTO.
Andiam, che in te è passata
la mezza notte, non che il mezzo dì.
Scena undicesima
Ottone, Drusilla.
OTTONE.
Io non so dov’io vada;
il palpitar del core,
et il moto del piè non van d’accordo.
L’aria, che m’entra in sen, quand’io respiro,
trova il cor mio sì afflitto, che pietosa,
ella si cangia in subitaneo pianto;
e così mentr’io peno,
l’aria per compassion mi piange in seno.
DRUSILLA.
E dove, Signor mio?
OTTONE.
Te sola io cerco.
DRUSILLA.
Eccomi a‘ tuoi piaceri.
OTTONE.
Drusilla, io vuo‘ fidarti
un secreto gravissimo, prometti
e silentio, e soccorso?
DRUSILLA.
Ciò che del sangue mio, non che dell’oro
può giovarti e servirti,
è già tuo più che mio.
Palesami il secreto,
che del silentio poi
ti do l’anima in pegno, e la mia fede.
OTTONE.
Non esser più gelosa
di Poppea; senti, io devo
hor hora per terribile comando
immergerle nel sen questo mio brando.
Per ricoprir me stesso
in misfatto sì enorme
io vorrei le tue vesti,
se occultarmi potrò, vivremo poi
uniti sempre in dilettosi amori:
se morir converammi,
nell’idioma d’un pietoso pianto
dimmi esequie o Drusilla;
se dovrò fuggitivo
scampar l’ira mortal di chi comanda,
soccorri a mie fortune.
DRUSILLA.
E le vesti, e le vene
ti darò volentieri;
ma circonspetto va‘, cauto procedi.
Nel rimanente sappi,
che le fortune, et le ricchezze mie
ti saran tributarie in ogni loco.
E proverai Drusilla
nobile amante, e tale,
che mai l’antica età non n’ebbe eguale.
Andiam pur, ch’io mi spoglio,
e di mia mano travestirti io voglio.
Ma vuo da te saper più a dentro, e a fondo
di così horrenda impresa la cagione.
OTTONE.
Andiam, andiam, homai,
che con alto stupore il tutto udrai.
Scena dodicesima
Poppea, Arnalta.
POPPEA.
Hor che Seneca è morto,
Amor, ricorro a te,
guida mie speme in porto,
fammi sposa al mio Re.
ARNALTA.
Pur sempre su le nozze
canzoneggiando vai.
POPPEA.
Ad altro, Arnalta mia, non penso mai.
ARNALTA.
Il più inquieto affetto
è la pazza ambitione;
ma se arrivi agli Scettri, e alle Corone,
non ti scordar di me,
tienmi appresso di te,
né ti fidar giammai di cortigiani,
perché in due cose sole
Giove è reso impotente:
ei non può far che in Cielo entri la morte,
né che la fede mai si trovi in Corte.
POPPEA.
Non dubitar, che meco
sarai sempre la stessa,
e non fia mai che sia
altra che tu la secretaria mia.
Par, che ‚l sonno m’alletti
a chiuder gl’occhi alla quiete in grembo.
Qui nel giardin, o Arnalta,
fammi apprestar del riposare il modo,
ch’alla fresc’aria addormentarmi io godo.
ARNALTA.
Udiste ancelle, o là!
POPPEA.
Se mi trasporta il sonno
oltre gli spatij usati
a risvegliar mi vieni,
né conceder l’ingresso nel giardino
fuor‘ ch’a Drusilla, o ad altre confidenti.
ARNALTA.
Adagiati, Poppea,
quietati, anima mia.
Sarai ben custodita.
Amanti, vagheggiate
il miracolo novo:
è luminoso il dì, sì come suole,
e pur vedete addormentato il Sole.
Oblivion soave
i dolci sentimenti
in te, figlia, addormenti.
Occhi ladri, occhi belli,
aperti deh che fate,
se chiusi anco rubbate?
Poppea, rimanti in pace;
luci care, e gradite,
dormite homai, dormite.
Scena tredicesima
AMOR scende dal Cielo, mentre Poppea dorme.
Dorme l’incauta, dorme,
ella non sa,
ch’or hor verrà
il punto micidiale;
così la humanità vive all’oscuro,
e quando ha chiusi gl’occhi,
crede essersi del mal posta in sicuro.
O sciocchi, o frali
sensi mortali,
mentre cadete in sonnacchioso oblio
su’l vostro sonno è vigilante Dio.
Siete rimasi
gioco dei casi,
oggetti al rischio, e del periglio prede,
se Amor genio del mondo non provede.
Dormi, o Poppea,
terrena Dea;
ti salverà dall’armi altrui rubelle
Amor, che move il Sole, e l’altre stelle.
Già s’avvicina
la tua ruina;
ma non ti nuocerà strano accidente,
ch’Amor picciolo è sì, ma onnipotente.
Scena quattordicesima
Ottone travestito, Amore, Poppea, Arnalta.
OTTONE.
Eccomi trasformato
non di Ottone in Drusilla,
ma d’huomo in serpe, a cui veneno, e rabbia
non vide il mondo, e non vedrà simile.
Ma che veggio, infelice?
Tu dormi anima mia? chiudesti gl’occhi
per non aprirli più? care pupille,
il sonno vi serrò,
affinchè non vediate
questi prodigi strani:
la vostra morte uscir dalle mie mani,
ohimè, trema il pensiero, il moto langue,
e ‚l cor fuor del suo sito
ramingo per le viscere tremanti
cerca un cupo recesso, per celarsi,
o involto in un singulto
ei tenta di scampar fuor di me stesso,
per non participar d’un tanto eccesso.
Adunque, adunque, ohimè!
tu resterai da me così tradito
bell’idolo addormito?
Passeran le tue luci
dal dolce sonno, ch’è una finta imago,
al vero originale della morte?
E le palpebre tue, che fan cortina
a due Stelle giacenti in grembo al sonno,
saranno hor hora tenebrosi avelli
a‘ due Soli gemelli?
Ma che tardo? Che bado?
Costei m’aborre, e sprezza, e ancor io l’amo?
Ho promesso ad Ottavia; se mi pento,
accelero a‘ miei dì funesto il fine.
Esca di Corte chi vuol esser pio.
Colui che ad altro guarda,
che all’interesse suo, merta esser cieco?
Il fatto resta occulto,
la macchiata coscienza
si lava finalmente con l’oblio.
Poppea t’uccido, Amor, rispetti, a Dio.
AMORE.
Forsennato, scelerato
inimico del mio nume,
tanto adunque si presume?
Fulminarti doverei,
ma non merti di morire
per la mano degli Dei.
Illeso va‘ da questi strali acuti,
non tolgo al manigoldo i suoi tributi.
POPPEA.
Drusilla, in questo modo
con l’armi ignude in mano,
mentre nel mio giardin dormo soletta?
ARNALTA.
Accorrete, accorrete,
o servi, o Damigelle,
in seguire Drusilla, dalli, dalli,
tanto mostro a ferir non fia chi falli.
Scena quindicesima
AMORE.
Ho difesa Poppea,
vuo‘ farla in questo giorno Imperatrice.
Hor al cielo men vado.
O bellissime Dame, o Cavalieri,
vado, e fra poco d’hora a voi ritorno.
Se forse impatienti
delle dimore mie
voleste ritrovarmi,
cercatemi per l’orme
delle bellezze amate,
nel cor de‘ Cavalieri,
negl’occhi delle Dame,
se voi ben guarderete,
sempre con l’armi in man mi troverete.
Fine dell’atto secondo
Atto terzo
Scena prima
DRUSILLA.
O felice Drusilla, o che sper’io?
Corre adesso per me l’hora fatale,
perirà, morirà la mia rivale,
e Ottone finalmente sarà mio.
Se le mie vesti
havran servito
per ben coprirlo,
con vostra pace, o Dei
adorar io vorrò gli arnesi miei.
O felice Drusilla, o che sper’io? etc.
Scena seconda
Drusilla, Arnalta, Littori.
ARNALTA.
Ecco la scelarata
che pensando occultarsi,
di vesti s’è mutata.
LITTORI.
Fermati, morta sei.
DRUSILLA.
E qual peccato mi conduce a morte?
LITTORI.
Ancor t’infingi, sanguinaria indegna?
A Poppea dormiente
machinasti la morte.
DRUSILLA.
Ahi, caro amico, ahi, sorte,
ahi mie vesti innocenti!
Di me doler mi devo, e non d’altrui,
credula troppo, e troppo incauta fui.
Scena terza
Arnalta, Nerone, Drusilla, Littori.
ARNALTA.
Signor, ecco la rea,
che uccidere tentò
la matrona Poppea;
l’innocente dormia nel suo giardino,
sopragiunse costei col ferro ignudo,
se non si risvegliava in un momento
la tua devota ancella,
sopra di lei cadeva il colpo crudo.
NERONE.
Onde tanto ardimento? e chi t’indusse
rubella al tradimento?
DRUSILLA.
Innocente son io,
lo sa la mia coscienza, e lo sa Dio.
NERONE.
Confessa homai, confessa, se t’indusse,
l’autoritade, o l’oro al gran misfatto.
DRUSILLA.
Innocente son io,
lo sa la mia coscienza, e lo sa Dio.
NERONE.
Tormenti, funi e fochi
cavino da costei
il mandante, e i correi.
DRUSILLA.
Misera me, più tosto,
che un atroce tormento
mi faccia dir, quel che ridir non voglio,
sopra me stessa toglio
la sentenza mortale, e il mancamento.
O voi, ch’al mondo vi chiamate amici,
specchiatevi hora in me,
questi del vero amico son gli uffici.
NERONE.
Che cinguetti, ribalda?
ARNALTA.
Che discorri, assassina?
LITTORI.
Che parli, traditrice?
DRUSILLA.
Mi contrastano in seno
con fiera concorrenza
Amore, e l’innocenza.
NERONE.
Prima ch’aspri tormenti
ti facciano sentire il mio disdegno
hor persuadi all’ostinato ingegno
di rivelar gl’orditi tradimenti.
DRUSILLA.
Signor, io fui la rea,
che uccidere tentò
l’innocente Poppea.
Quest’alma, e queta mano
fur le complici sole;
a ciò m’indusse un odio occulto antico;
non cercar più la verità ti dico.
NERONE.
Conducete costei
al manigoldo homai,
fate ch’egli ritrovi
con una morte a tempo
qualche lunga et asprissima agonia,
che inhorridisca il fine a questa ria.
DRUSILLA.
O mio verace amico,
amami almen sepolta,
e su ‚l sepolcro mio
mandino gl’occhi tuoi sola una volta
dalle fonti del core
lagrime di pietà, se non d’amore;
ch’io vado vera amica, e fida amante
fra i manigoldi irati
a coprir col mio sangue i tuoi peccati.
NERONE.
Che si tarda, o ministri,
provi, provi costei
mille morti hoggi mai, mille ruine.
Scena quarta
Ottone, Nerone, Drusilla.
OTTONE.
No, no, questa sentenza
cada sopra di me, che ne son degno;
siatemi testimonij, o Cieli, o Dei!
Innocente è costei.
Io con le vesti di Drusilla andai,
per ordine d’Ottavia imperatrice
ad attentar la morte di Poppea.
Giove, Nemesi, Astrea,
fulminate il mio capo,
che per giusta vendetta
il patibolo orrendo a me s’aspetta.
Dammi, Signor, con la tua man la morte;
e se non vuoi, che la tua mano adorni
di decoro il mio fine,
mentre della tua grazia io resto privo,
all’infelicità lasciami vivo.
Se tu vuoi tormentarmi
la mia coscienza ti darà i flagelli,
se a leoni, et agl’Orsi espormi vuoi,
dammi in preda al pensier delle mie colpe,
ch’ei mi divorerà l’ossa e le polpe.
NERONE.
Vivi, ma va ne‘ più remoti lidi
di titoli spogliato, e di fortune,
e serva a te mendico, e derelitto,
di flagello, e spelunca il tuo delitto.
E tu ch’ardisti, o nobile matrona,
per ricoprir costui
d’apportar salutifere bugie,
vivi alla fama della mia clemenza,
vivi alle glorie della tua fortezza,
e sia del sesso tuo nel secol nostro
la tua costanza un adorabil mostro.
DRUSILLA.
In esilio con lui,
deh, Signor mio consenti,
ch’io tragga i dì ridenti.
NERONE.
Vanne come ti piace.
OTTONE.
Signor, non son punito, anzi beato;
la virtù di costei
sarà ricchezza, e gloria a‘ giorni miei.
DRUSILLA.
Ch’io viva, e mora teco: altro non voglio.
Dono alla mia fortuna
tutto ciò che mi diede,
purché tu riconosca
in cor di donna una costante fede.
NERONE.
Delìbero, e risolvo
il ripudio d’Ottavia,
e con perpetuo esilio
da Roma io la proscrivo.
Sia pur condotta al più vicino lido.
Le s’appresti in momenti
qualche spalmato legno,
e sia commessa al bersagliar dei venti.
Convengo giustamente risentirmi
volate ad ubbidirmi.
Scena quinta
Poppea, Nerone.
POPPEA.
Signor, hoggi rinasco,
e questa nova vita
spender voglio in sospiri,
che ti faccian sicuro
che rinata per te languisco, e moro,
e morendo, e vivendo ogn’hor t’adoro.
NERONE.
Non fu, non fu Drusilla,
ch’ucciderti tentò.
POPPEA.
Chi fu chi fu il fellone?
NERONE.
Il nostro amico Ottone.
POPPEA.
Egli da sé?
NERONE.
D’Ottavia fu il pensiero.
POPPEA.
Hor hai giusta cagione
di passare al ripudio.
NERONE.
Hoggi, come promisi,
mia sposa tu sarai.
POPPEA.
Sì caro dì veder non spero mai.
NERONE.
Per il nome di Giove, e per il mio,
te l’affermo e tel giuro,
hoggi sarai mia sposa,
in parola regal te n’assicuro.
POPPEA.
Idolo del mio cor, giunta è pur l’hora,
ch’io del mio ben godrò,
né più s’interporrà noia, o dimora.
Cor nel seno io non ho:
me’l rubbasti sì sì,
dal sen me lo rapì,
de‘ tuoi begl’occhi il lucido sereno,
per te, mio ben, non ho più core in seno.
NERONE.
Stringerò tra le braccia innamorate,
chi mi trafisse ohimè!
Non interrotte avrò l’hore beate.
Se son perduto in te,
in te mi cercarò,
in te mi trovarò,
e tornerò a riperdermi, cor mio,
che sempre in te perduto esser vogl’io.
Scena sesta
OTTAVIA sola.
A Dio, Roma, a Dio Patria, amici a Dio.
Innocente da voi partir convengo.
Io vado a distillarmi in pianti amari,
navigo disperata i sordi mari.
L’aria che d’hora in hora
riceverà i miei fiati,
li porterà per nome del cor mio
a veder, a baciar le patrie mura,
et io starò solinga,
alternando le mosse ai pianti, ai passi
insegnando pietade ai tronchi e ai sassi,
ahi, sacrilego duolo,
tu m’interdici il pianto,
mentre lascio la patria
né stillar una lagrima poss’io;
mentre dico ai parenti, e a Roma a Dio.
Scena settima
ARNALTA sola.
Hoggi sarà Poppea
di Roma Imperatrice
io, che son sua nutrice,
ascenderò delle grandezze i gradi:
no no col volgo io non m’abbasso più;
chi mi diede del tu,
hor con nova armonia
gorgheggierammi il Vostra Signoria.
Chi m’incontra per strada
mi dice fresca donna, e bella ancora,
et io pur so, che sembro
delle Sibille il leggendario antico,
ma ognun‘ così m’adula,
credendo guadagnarmi,
per interceder gratie da Poppea.
Et io fingendo non capir le frodi,
in coppa di bugia bevo le lodi.
Io nacqui serva, e morirò matrona.
Mal volentier morrò;
se rinascessi un dì,
vorrei nascer matrona, e morir serva.
Chi lascia le grandezze,
piangendo a morte va,
ma chi servendo sta,
con più felice sorte,
come fin degli stenti ama la morte.
Scena ottava
Nerone, Poppea, Consoli, Tribuni, Amor, Venere in Cielo, et Choro d’Amori.
NERONE.
Ascendi, o mia diletta,
della sovrana altezza
all’apice sublime,
circondata di glorie,
ch’ambiscono servirti, come ancelle.
Acclamata dal mondo, e dalle stelle,
siano del tuo trionfo
tra i più cari trofei,
adorata Poppea, gli affetti miei.
POPPEA.
La mia mente confusa
al non usato lume
quasi perde il costume,
signor, di ringraziarti.
Su queste eccelse cime,
ove mi collocasti,
per venerarti a pieno,
io non ho cor che basti.
Doveva la natura
al soprapiù degli eccessivi affetti,
un core a parte fabbricar ne‘ petti.
NERONE.
Per capirti ne‘ gli occhi
il Sol s’impicciolì,
per albergarti in seno
l’alba dal Ciel partì,
e per farti sovrana a donne, e a Dee,
Giove nel tuo bel volto
stillò le stelle, e consumò l’Idee.
POPPEA.
Da‘ licenza al mio spirto,
ch’esca dall’amoroso labirinto
di tante lodi, e tante.
E che s’humilij a te, come conviene,
mio Re, mio sposo, mio Signor, mio bene.
NERONE.
Ecco vengono i Consoli, e i Tribuni,
per riverirti, o cara:
nel solo rimirarti,
il popolo, e ‚l Senato
homai comincio a diventar beato.
CONSOLI E TRIBUNI.
A te, sovrana Augusta
con il consenso universal di Roma
indiademiam la chioma;
a te l’Asia, a te l’Africa s’atterra;
a te l’Europa e il mar, che cinge e serra
questo Imperio felice,
hora consacra, e dona
questa del mondo Imperial Corona.
AMORE.
Scendiam, scendiamo
compagni alati.
CHORO d’Amori.
Voliam, voliamo
a sposi amati.
AMORE.
Al nostro volo
risplendano assistenti i sommi Divi.
CHORO d’Amori.
Dall’alto polo
si veggian fiammeggiar raggi più vivi.
AMORE.
Se i Consoli, e i Tribuni,
Poppea, t’han coronato
sovra Provincie, e Regni,
hor ti corona Amor, donna felice,
come sopra le belle, Imperatrice,
o madre, con tua pace,
in Ciel tu sei Poppea,
questa è Venere in terra,
a cui per riverirla,
ogni forma creata hoggi s’atterra.
VENERE.
O figlio, io mi compiaccio
di quanto aggrada a te;
diasi pur a Poppea
il titolo di Dea.
AMORE.
Hor cantiamo giocondi,
festeggiamo ridenti in terra, e in Cielo,
il gaudio sovrabbondi,
e in ogni clima, in ogni Regïone
si senta rimbombar Poppea, Nerone.
Il fine dell’opera